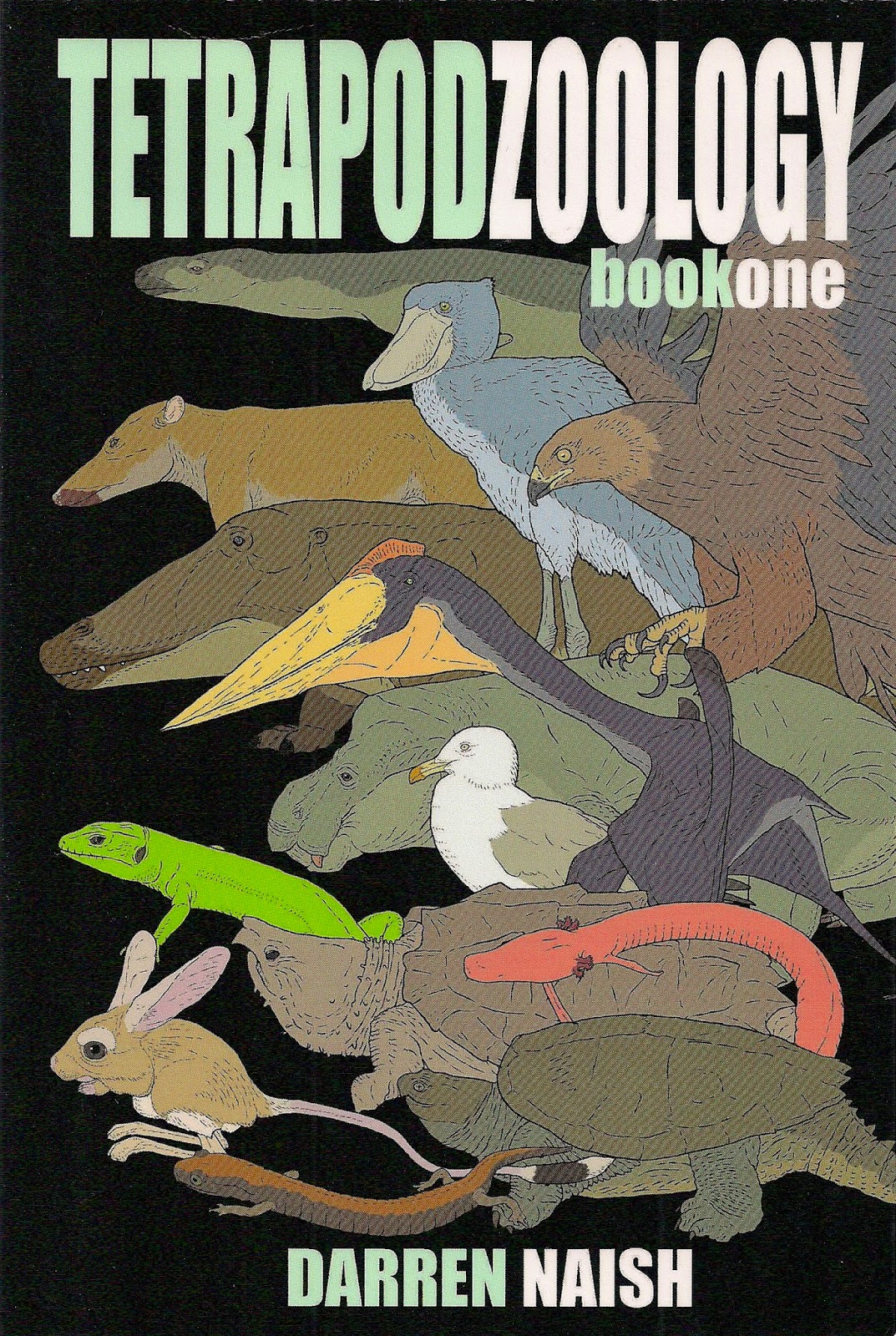|
| "Quando i dinosauri dominavano la terra" (cit.). Crichton, M. 1991. Jurassic Park. London: Arrow - Random House (rist.); fotografia dell'autore. |
Nel 1997, Michael Crichton scrisse un’introduzione per la monumentale Encyclopedia of Dinosaurs, nella quale si celebrava per la prima volta in un’opera accademica di tali dimensioni la scoperta di dinosauri piumati [1]. Interrogatosi sui motivi che giustificherebbe la smodata passione per i dinosauri, Crichton elencò puntigliosamente sei ipotesi che potessero spiegarne diffusione e stabilità, tutte falsificate empiricamente:
- la dinomania colpirebbe i paesi dotati di ricchi giacimenti fossiliferi, ma è diffusa anche in paesi con pochi fossili, come Italia o Giappone;
- la dinomania rifletterebbe un interesse prettamente infantile, ma gli adulti non sono immuni al fascino dei dinosauri;
- la dinomania sarebbe il risultato di una sottocultura infantile, ma la figlia di Crichton espresse interesse nei confronti dei dinosauri ben prima di andare a scuola e persino prima di poter parlare;
- la dinomania si imporrebbe grazie alle dimensioni esagerate dei dinosauri, ma dinosauri più piccoli suscitano le medesime emozioni;
- la dinomania affascinerebbe perché i dinosauri sarebbero un qualcosa di irrimediabilmente perduto durante l’estinzione di massa risalente a ca. 65 milioni di anni fa, ma una volta allo zoo la figlia dello scrittore chiese dove fossero i dinosauri (pur essendo già stata allo zoo credeva fossero tenuti in una zona nascosta del parco zoologico);
- la conoscenza dei dinosauri corrisponderebbe a un freudiano senso di controllo sulla realtà, per ridurre l’ansia di essere impotenti e privi di autorità, ma quando la figlia di Crichton venne portata sul set di Jurassic Park insieme ad alcune amiche queste furono talmente angosciate dalla visione degli animatronic che vollero essere riaccompagnata a casa [2].
Alla fine dell’excursus, Crichton concluse che la dinomania non si spiega e che sembra destinata a restare un mistero. «Il mistero», così scrisse, «è parte del [loro] fascino» [3].
Non è questo il luogo dove domandarsi quanto la mancanza di un gruppo di controllo, o l’inadeguata esplorazione della dimensione cognitiva, o la mancata constatazione che la stessa domanda potrebbe essere posta per qualunque argomento della ricerca sufficientemente noto a livello popolare (atomi, pianeti, trilobiti, ecc.), o ancora la scarsa attenzione alla contestualizzazione storico-geografica, abbiano nuociuto all’interessante esperimento mentale di Crichton. Come aveva con più arguzia argomentato Stephen Jay Gould, ad esempio, la dinomania è una moda diffusa nell’emisfero culturale Occidentale, esplosa nella seconda metà del Novecento e potenziata dalla produzione di massa [4]. E, paradossalmente, dall’introduzione emerge proprio l’incapacità o l’avversione nutrita da Crichton nei confronti del pensarsi come agente e insider nel campo culturale, dato che i suoi sono due celeberrimi romanzi (Jurassic Park e Il mondo perduto) hanno contribuito come pochi altri a potenziare oltremodo la dinomania e, meritatamente, a svecchiare l’immagine dei dinosauri presso il pubblico generalista.
Piuttosto, ciò che vorrei sottolineare qui è che l’introduzione enciclopedica dell’autore di Jurassic Park ha valore letterario e in quanto tale serve allo scopo prefissato: produrre meraviglia giocando di sottrazione. Il finale è esplicativo in questo senso:
«Nonostante sappiamo oggi molto di più sui dinosauri di quanto non conoscessimo un decennio fa, la verità è che ne sappiamo ancora molto poco. Non sappiamo veramente come apparissero o come si comportassero queste creature. Abbiamo qualche osso, impronte della loro pelle, qualche pista di orme, e molte affascinanti speculazioni sulla loro biologia e organizzazione sociale. Tuttavia, le prove che ci rimangono del loro mondo svanito da tempo sono stuzzicanti e incomplete. Pertanto, i dinosauri stimolano i nostri sogni. E probabilmente continueranno a farlo sempre» [5].
“Stuzzicanti” e “incomplete” sono le due parole chiave dell’intero discorso crichtoniano. Paradossalmente, sono parole la cui giustapposizione produce un’ambiguità potenzialmente divergente. Se dal punto di vista scientifico è l’incompletezza stessa a stuzzicare il riconoscimento di pattern nel mondo reale, e a spronare verso una maggiore conoscenza ontologica della realtà, artisticamente invece l’incompletezza può condurre a un decontestualizzante potenziamento in chiave fantastica. Non che sia necessariamente un male, sia chiaro. Scienza e arte, se adeguatamente dosate, producono risultati sorprendenti. Ma la chiave di volta crichtoniana è che l’incompletezza starebbe giocoforza al di là del raggiungibile e, pertanto, la speculazione diventerebbe il mezzo corretto e giustificato per rendere conto del mistero che sono – e saranno sempre – i dinosauri. Per questi motivi che fondano un imperscrutabile e perdurante mistero, l’intero messaggio crichtoniano, posto in epigrafe ad un’opera enciclopedica e accademica, redatta in un momento di incredibili scoperte paleontologiche (risale al 1996 la conferma della presenza di tegumento filamentoso nel primo dinosauro piumato, Sinosauropteryx prima, raffigurato sulla copertina dell’Encyclopedia of Dinosaurs da Michael Skrepnick), è delegittimante e straniante.
 |
| Un Sinosauropteryx prima immortalato da Michael Skrepnick. Dalla copertina di Currie, P.J. & K. Padian (eds.) 1997. Encyclopedia of Dinosaurs. San Diego – London: Academic Press. |
Tempo fa avevamo incontrato un altro scrittore le cui esternazioni scientifiche mi avevano fatto storcere il naso e spinto ad effettuare un po’ di salutare fact-checking. Ma nel caso di Crichton c’è un altro aspetto di fondo che andrebbe adeguatamente valutato e sul quale vorrei soffermarmi.
In Jurassic Park e ne Il mondo perduto (sia i romanzi pubblicati rispettivamente nel 1990 e nel 1995, sia i due adattamenti con Steven Spielberg dietro alla macchina da presa, usciti nel 1993 e nel 1997), l’intento di fondo è quello di allertare il lettore nei confronti delle conseguenze impreviste, imprevedibili e contingenti della manipolazione tecnoscientifica.
Detto per inciso, si tratta di due tra i miei romanzi preferiti di sempre. Nonostante le debolezza di alcune parti della trama, sono due opere artistiche dall’indiscutibile valore culturale sia per la capacità di alimentare interessanti dibattiti intorno alla scienza sia per la loro qualità intrinseca. Per non parlare dei due lungometraggi, pietre miliari tra i blockbuster moderni, pionieristici per il sapiente uso di animatronic e tecniche digitali e semplicemente fondamentali per il mio personale bagaglio di amarcord. Il primo di questi, infine, contrassegna l’apogeo del lato più avventuroso della produzione di Spielberg, premiato con tre Oscar. E scusate se è poco.
Ciò nondimeno, la passione non può e non dovrebbe mai accecare il senso critico. Riconoscere il valore di un’opera artistica non significa giustificarne in toto i temi espliciti ed impliciti ma, anzi, l’apprezzamento dovrebbe indurre a decostruire l’opera per osservarne la macchina narrativa dall’interno e per sottoporne ad un’analisi serrata i contenuti. L’affezione bypassa il senso critico, creando un cortocircuito logico che tende ad offuscare eventuali problemi inerenti all’opera in questione. E, se analisi deve essere, non si può evitare di interrogarsi in ultima istanza sul peso che ha avuto l’opera di Crichton nella ricezione e diffusione della peculiare idea di scienza che egli ha saputo così abilmente veicolare. Perché un’opera artistica il cui messaggio sia sufficientemente diffuso può avere pericolose ricadute reali nel mondo al di fuori della celluloide e dei bit. L’impennata delle vendite di cuccioli dalmata – prontamente abbandonati – dopo La carica dei 101 (il live action Disney del 1996), e il crollo della popolazione dei pesci pagliaccio dopo Alla ricerca di Nemo (Pixar, 2003), sono solo due tristi e stranoti esempi [6].
Ciò nondimeno, la passione non può e non dovrebbe mai accecare il senso critico. Riconoscere il valore di un’opera artistica non significa giustificarne in toto i temi espliciti ed impliciti ma, anzi, l’apprezzamento dovrebbe indurre a decostruire l’opera per osservarne la macchina narrativa dall’interno e per sottoporne ad un’analisi serrata i contenuti. L’affezione bypassa il senso critico, creando un cortocircuito logico che tende ad offuscare eventuali problemi inerenti all’opera in questione. E, se analisi deve essere, non si può evitare di interrogarsi in ultima istanza sul peso che ha avuto l’opera di Crichton nella ricezione e diffusione della peculiare idea di scienza che egli ha saputo così abilmente veicolare. Perché un’opera artistica il cui messaggio sia sufficientemente diffuso può avere pericolose ricadute reali nel mondo al di fuori della celluloide e dei bit. L’impennata delle vendite di cuccioli dalmata – prontamente abbandonati – dopo La carica dei 101 (il live action Disney del 1996), e il crollo della popolazione dei pesci pagliaccio dopo Alla ricerca di Nemo (Pixar, 2003), sono solo due tristi e stranoti esempi [6].
Compongono la linea di basso continua che accompagna i due romanzi di Crichton una serie di paradossi, la cui irrisolta dialettica narrativa sostiene strutturalmente e fornisce il giusto ritmo alle posizioni espresse dai vari personaggi. A monte troviamo il leitmotiv dell’incapacità umana di controllare le innovazioni scientifiche e il tema della natura come riparatrice di un equilibrio alterato, nel contempo appellando ideologicamente alla natura come ente morale. Nulla di più sbagliato: la natura non è un ente antropomorfico, non agisce teleologicamente e la cultura non è qualcosa di avulso dalla natura ma ne è un’espressione precipua, in Homo sapiens così come in altri animali non-umani. Non esiste alcuno stato di natura perfetto, né condizioni primigenie naturalmente “buone”. Nell’ottica di Jurassic Park, tuttavia, il tempo profondo dell’evoluzione “seleziona per l’estinzione” (un nonsense paleontologico proferito da Ian Malcolm nel lungometraggio e riferito ovviamente ai dinosauri), e dato che è orientato a senso unico su una strada che ha un punto d’arrivo preciso, dona un senso di statica necessità all’essere umano. E se l’essere umano osa violare i pattern stabiliti dalla natura, che agisce come ente morale, non gli rimane che aspettarsi una punizione per le sue azioni “contro natura” [7]. Un’argomentazione davvero poco scientifica e molto ideologica da parte del caosologo, sulla quale insisteremo di nuovo sul finale del post.
Notiamo per ora che qui si consuma il primo paradosso: i dinosauri di Jurassic Park sarebbero stati selezionati per l’estinzione (poco importa se gli attuali dinosauri aviani, gli uccelli, rappresentano la classe di vertebrati più diffusa al mondo) ma, una volta riportati in vita ed ingabbiati, alla prima occasione lottano per la loro libertà surclassando i loro antagonisti umani, evidentemente non più baciati dalla fortuna evoluzionistica [7bis]. Non male, per chi era stato selezionato per estinguersi.
Ma la colpa di quanto accaduto non è dei dinosauri, che sono solo agenti di fortuna di qualcosa di più grande e malvagio. Oltre alla demonizzazione dell’infantile sogno di Hammond, la colpa sembra ricadere sugli scienziati assoldati dalla InGen, plagiati dal capitalismo.
Notiamo per ora che qui si consuma il primo paradosso: i dinosauri di Jurassic Park sarebbero stati selezionati per l’estinzione (poco importa se gli attuali dinosauri aviani, gli uccelli, rappresentano la classe di vertebrati più diffusa al mondo) ma, una volta riportati in vita ed ingabbiati, alla prima occasione lottano per la loro libertà surclassando i loro antagonisti umani, evidentemente non più baciati dalla fortuna evoluzionistica [7bis]. Non male, per chi era stato selezionato per estinguersi.
Ma la colpa di quanto accaduto non è dei dinosauri, che sono solo agenti di fortuna di qualcosa di più grande e malvagio. Oltre alla demonizzazione dell’infantile sogno di Hammond, la colpa sembra ricadere sugli scienziati assoldati dalla InGen, plagiati dal capitalismo.
Crichton, che aveva studi medici alle spalle e che era pronto a documentarsi scientificamente con rigore prima di stendere un romanzo, condivideva idee tipiche della sociologia della scienza postmodernista, e tendeva a vedere scienziati e ricercatori come esseri umani fallaci, mossi da sentimenti e desideri umani, spesso potenzialmente deleteri. Visione legittima e necessaria per riconsiderare il mito delle magnifiche sorti e progressive, eppure, ciò non sempre ha condotto a una visione d’insieme più equilibrata. Ben nota è la posizione negazionista che lo scrittore assunse riguardo all’attività antropogenica come causa scatenante del riscaldamento climatico. Non pago, Crichton si spinse ad appaiare deplorevolmente gli scienziati che denunciavano l’attività umana come principale agente dell’attuale riscaldamento globale all’orrorifico spauracchio eugenetico nel suo romanzo Stato di paura, pubblicato in inglese nel 2004 e tradotto in italiano l’anno successivo [8].
Come ha scritto Sandy Becker, «È difficile per uno scienziato provare simpatia per Michael Crichton. Lo scrittore sembra essere veramente ostile alla scienza e alle persone che la praticano» [9], perché gli studiosi e i ricercatori dei suoi due romanzi a tema genetico de-estinzionista sono o attirati dalle lusinghe delle compagnie private che devono capitalizzare e produrre profitto, compagnie pronte a qualunque mezzo lecito ed illecito pur di raggiungere i propri loschi obiettivi finanziari (un tema riflesso nel personaggio senza scrupoli di Lewis Dodgson in entrambi i libri), oppure si lanciano in acide o nostalgiche esternazioni sulla devastazione prodotta da una scienza che avrebbe tradito i suoi presupposti di pura conoscenza ed è ora pronta a manipolare e depredare la natura (ad esempio, Ian Malcolm - alter ego di Crichton - in Jurassic Park e Marty Gutierrez ne Il mondo perduto). Tertium no datur.
Come ha scritto Sandy Becker, «È difficile per uno scienziato provare simpatia per Michael Crichton. Lo scrittore sembra essere veramente ostile alla scienza e alle persone che la praticano» [9], perché gli studiosi e i ricercatori dei suoi due romanzi a tema genetico de-estinzionista sono o attirati dalle lusinghe delle compagnie private che devono capitalizzare e produrre profitto, compagnie pronte a qualunque mezzo lecito ed illecito pur di raggiungere i propri loschi obiettivi finanziari (un tema riflesso nel personaggio senza scrupoli di Lewis Dodgson in entrambi i libri), oppure si lanciano in acide o nostalgiche esternazioni sulla devastazione prodotta da una scienza che avrebbe tradito i suoi presupposti di pura conoscenza ed è ora pronta a manipolare e depredare la natura (ad esempio, Ian Malcolm - alter ego di Crichton - in Jurassic Park e Marty Gutierrez ne Il mondo perduto). Tertium no datur.
Si può nondimeno ipotizzare che l’opera di Crichton possa aver in qualche modo contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di un maggiore controllo statale sulle iniziative private a scopo di lucro, e a suggerire implicitamente maggiori finanziamenti pubblici per la ricerca [9bis]. Eppure, elementi narrativi come la svalutazione dell’attività accademica e la mancata differenziazione tra ricerca accademica e ricerca privata, o tra scienza e sfruttamento tecnologico delle scoperte scientifiche tout court, indicano piuttosto chiaramente l’opinione dell’autore, che resta negativa in termini assoluti [10]. Oltre al mistero di cui al primo paragrafo, un esempio lampante del primo punto si può trovare nel discorso del primo romanzo con il quale il magnate aziendale John Hammond convince il genetista Henry Wu a lavorare per la InGen, lasciando perdere la ricerca accademica, mentre per il secondo, mentre per quanto riguarda il secondo basti ricordare che scienza e tecnologia non sono la stessa cosa, come ricordavo anche al secondo paragrafo di questo lungo post. In fin dei conti, tra la tecnologia robotica di Westworld (in italiano, Il mondo dei robot), il parco di attrazioni dedicato al selvaggio West popolato da androidi iperrealistici e tramutati in macchine assassine da un virus informatico (nonché ultimo grande film del genere Western ormai al tramonto, scritto e diretto da Crichton nel 1973) e i genetisti arrivisti di Jurassic Park, non c’è iato: dato che i presupposti sono gli stessi (la commercializzazione di un prodotto da vendere), l’esito catastrofico è il medesimo [11].
 |
| Westworld (1973). Fonte: IGN. |
Sono pessimista di natura, forse anche più di Crichton, e non trovo difficoltà alcuna ad immaginarmi devastazioni antropogeniche dovuto ad un ipertrofico exploit della temutissima legge di Murphy su scala globale. Il triste elenco degli ingenti danni ecologici già accaduti in passato a causa dell’incuria umana è una moneta corrente talmente svalutata che credo sia perfino inutile fornire qui un elenco. Ma gli elementi che lo scrittore posiziona con cura sul tavolo apparecchiato per il lettore o per lo spettatore (Crichton fu coautore della sceneggiatura del primo film di Spielberg) falsano l’opinione alla quale essi possono giungere: dal discorso morale di Malcolm, pronto a pontificare sulla “mancanza di umiltà” di fronte alla natura, ci vuole solo un battito di ciglia per passare a posizioni retrograde e senza fondamento scientifico come la lotta contro gli OGM o contro la ricerca sulle cellule staminali. Oggi Malcolm, cattedratico ormai in pensione, sarebbe un perfetto troll della Rete.
Come ho scritto altrove [12],
«dato che incrementando le conoscenze aumentano anche le zone i cui confini vengono appena lambiti dalle nuove acquisizioni concettuali, sancendo il perenne mantenimento di un’ignoranza relativa (mai assoluta) che si sposta rispetto all’avanzamento stesso delle conoscenze, i cosiddetti «limiti della scienza […] nel momento in cui stabiliscono i confini di un universo di discorso dato, aprono nuove possibilità per la costruzione di nuovi universi di discorso» [13]. Inoltre, per fare ricerca è necessario sbagliare, e nell’immagine mediatica comunemente diffusa vengono minimizzate le ore di tempo buttate nel perseguire fruttuosamente strade rivelatesi errate (l’ossimoro è voluto). Come ha ricordato Medawar, calcolo che, per tutto il vantaggio che ne ha tratto la scienza [nonostante l’ironia, ricordo che Peter Brian Medawar fu premio Nobel per la Medicina. N.d.A.], circa quattro quinti del mio tempo s[ono] stati sciupati inutilmente, e ritengo che lo stesso sia avvenuto a tutti coloro che non s’accontentano di seguire ciecamente le direttive del proprio capo nella ricerca [14]».
Tutto ciò nel mondo di Crichton non c’è o, meglio, non ricopre alcun ruolo effettivo. Possiamo essere tranquillamente d’accordo sulla necessità di controllare gli investimenti privati nel campo della ricerca, ma non si può fare un tutt’uno tra elementi così disparati (pubblico e privato, scienza e tecnologia, ricerca e commercializzazione, ecc.). La ricerca di per sé è contingente, e prodotti secondari non prevedibili possono condurre a svolte prima impensabili. Nei mondi fittizi immaginati da Crichton quali eccezionali applicazioni mediche potrebbero aver avuto gli strabilianti meccanismi robotici di Westworld? Quali terapie genetiche sarebbero state perfezionate grazie alla ricerca ancora oggi avanguardistica della InGen?
Torniamo per un istante all’iconica scena del pranzo nel lungometraggio di Spielberg. Mentre si trova a tavola, il matematico solleva importanti questioni di bioetica, eppure tutto appare irrimediabilmente offuscato dal vieto e insostenibile richiamo ad un ordine comportamentale naturale da osservare per non incappare nella punizione morale, sul quale abbiamo già detto. Basti qui ricordare che questi richiami alla naturalità della morale e alla moralità della natura nascondono sempre implicite macchinazioni ideologiche e che in natura il naturale così dogmaticamente inteso non esiste, tanto meno in quello sessuale-riproduttivo (clonazione dei dinosauri inclusa). In natura c’è tutto e il contrario di tutto: «Il mondo naturale è del tutto indifferente ai nostri interrogativi morali [...]. La sua norma, se proprio vogliamo trovarne una, è quella della diversità delle soluzioni adattative e comportamentali, dell'esplosione contingente di possibilità» [15]. A cosa pensava Alan Grant, il paleontologo, quando c’era più bisogno di un suo intervento per controbattere le strumentalizzazioni ideologiche di Malcolm?
A ciò si aggiunga che il caosologo, nell’evocazione retorica di spaventosi spettri nucleari allo scopo di ispirare nei suoi interlocutori le temibili conseguenze di una irrispettosa manipolazione della natura (e per zittire aprioristicamente qualunque possibile obiezione), sorvola sul fatto che quella stessa tecnologia di bombardamento degli atomi ha permesso, mutatis mutandis, di salvare vite umane grazie alla radiodiagnostica [15bis]. Cercare di contenere a priori la scienza non solo è controproducente, ma è del tutto fallimentare. La curiosità è da sempre parte integrante dell’essere umano. La ricerca non parte con il presupposto esplicito di arrivare a un obiettivo prestabilito, evitando dogmaticamente zone vietate, ma esplora a tutto tondo il reale e interagisce secondo modalità inaspettate con tutti gli altri campi del sapere, a patto di rispettare le condizioni ontologiche del campo sociologico: dal cannocchiale di Galileo ai satelliti in orbita che ci permettono di comunicare, conoscere la nostra posizione sul pianeta Terra e quant’altro, non c’è cesura, così come da van Leeuwenhoek e Darwin alla rincorsa per nuovi e più efficaci antibiotici.
E qui sta il secondo paradosso di Crichton: lo scrittore, forte di una preparazione accademico-scientifico e medica, non ha certamente propagandato un oscurantismo teologico, ma gridare costantemente “Al lupo! Al lupo!” riguardo ai potenziali pericoli causati dalla scienza che filtrano dai romanzi e permeano i citati lungometraggi, falsa la distinzione tra ricerca accademica, ricerca tecnologica su base aziendale con fini di lucro e applicazione e capitalizzazione dei risultati della ricerca a livello industriale. Sfruttando l’abusata retorica del pericolo della “tecnoscienza”, condita da disquisizioni teleologiche sulla disumanità dell’attuale ricerca come blasfema sfida prometeica, Crichton cavalca cliché già teologici e manca clamorosamente l’obiettivo, poiché i responsabili a monte del sistema che intende denunciare nella sua fiction narrativa sarebbero piuttosto i rappresentanti politici democraticamente eletti, ai quali spetterebbe la sorveglianza e il controllo di simili avvenimenti [16]. E invece ciò non accade, poiché è più semplice scaricare la colpa attivando il tropo dello scienziato ingenuo, sprovveduto o semplicemente pazzo, toccando corde di sicuro effetto presso il pubblico, per quanto di scarsa aderenza alla realtà.
A ciò si aggiunga che il caosologo, nell’evocazione retorica di spaventosi spettri nucleari allo scopo di ispirare nei suoi interlocutori le temibili conseguenze di una irrispettosa manipolazione della natura (e per zittire aprioristicamente qualunque possibile obiezione), sorvola sul fatto che quella stessa tecnologia di bombardamento degli atomi ha permesso, mutatis mutandis, di salvare vite umane grazie alla radiodiagnostica [15bis]. Cercare di contenere a priori la scienza non solo è controproducente, ma è del tutto fallimentare. La curiosità è da sempre parte integrante dell’essere umano. La ricerca non parte con il presupposto esplicito di arrivare a un obiettivo prestabilito, evitando dogmaticamente zone vietate, ma esplora a tutto tondo il reale e interagisce secondo modalità inaspettate con tutti gli altri campi del sapere, a patto di rispettare le condizioni ontologiche del campo sociologico: dal cannocchiale di Galileo ai satelliti in orbita che ci permettono di comunicare, conoscere la nostra posizione sul pianeta Terra e quant’altro, non c’è cesura, così come da van Leeuwenhoek e Darwin alla rincorsa per nuovi e più efficaci antibiotici.
E qui sta il secondo paradosso di Crichton: lo scrittore, forte di una preparazione accademico-scientifico e medica, non ha certamente propagandato un oscurantismo teologico, ma gridare costantemente “Al lupo! Al lupo!” riguardo ai potenziali pericoli causati dalla scienza che filtrano dai romanzi e permeano i citati lungometraggi, falsa la distinzione tra ricerca accademica, ricerca tecnologica su base aziendale con fini di lucro e applicazione e capitalizzazione dei risultati della ricerca a livello industriale. Sfruttando l’abusata retorica del pericolo della “tecnoscienza”, condita da disquisizioni teleologiche sulla disumanità dell’attuale ricerca come blasfema sfida prometeica, Crichton cavalca cliché già teologici e manca clamorosamente l’obiettivo, poiché i responsabili a monte del sistema che intende denunciare nella sua fiction narrativa sarebbero piuttosto i rappresentanti politici democraticamente eletti, ai quali spetterebbe la sorveglianza e il controllo di simili avvenimenti [16]. E invece ciò non accade, poiché è più semplice scaricare la colpa attivando il tropo dello scienziato ingenuo, sprovveduto o semplicemente pazzo, toccando corde di sicuro effetto presso il pubblico, per quanto di scarsa aderenza alla realtà.
Purtroppo, questo secondo paradosso si è ripetuto con il recentissimo quarto appuntamento del franchise cinematografico di Jurassic Park, affrancatosi da Crichton già dal terzo episodio risalente al 2000 e con Joe Johnston in cabina di regia. Ma di questo parleremo nel prossimo post.
[1] Currie, P.J. & K. Padian (eds.) 1997. Encyclopedia of Dinosaurs. San Diego – London: Academic Press. Cf. la storica e brevissima voce firmata da Currie (sedici righe di testo), intitolata Feathered Dinosaurs, in ibi: 241.
[2] Crichton, M. 1997. Foreword. In: Currie, P.J. & K. Padian (eds.) 1997. Encyclopedia of Dinosaurs. San Diego – London: Academic Press. pp. xxv-xxvi.
[3] Ibi: xxvi.
[4] Gould, S.J. (1995). Dinomania Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural History, 221-237 DOI: 10.4159/harvard.9780674063426.c26. Recensione pubblicata originariamente nel 1993 come Dinomania. Jurassic Park, directed by Steven Spielberg, screenplay by Michael Crichton, by David Koepp . Universal city studios; The Making of Jurassic Park by Don Shay, by Jody Duncan, Ballantine, 195 pp., $18.00 (paper); Jurassic Park, by Michael Crichton, Ballantine, 399 pp., $6.99 (paper). «New York Review of Books», August, 12: <http://www.nybooks.com/articles/archives/1993/aug/12/dinomania/?pagination=false>.
[5] Crichton, M. 1997. Foreword, cit: xxvi.
[6] Zarrella, J. 1997. With Movie Craze Over, Woman Helps Dalmatians Find Homes. CNN Interactive, May 6, <http://edition.cnn.com/US/9705/06/dal/index.html>; Alleyne, R. 2008. Demand for Real Finding Nemo Clownfish Putting Stocks at Risk. The Telegraph, June 26, < http://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/3345594/Demand-for-real-Finding-Nemo-clownfish-putting-stocks-at-risk.html> (ultimo accesso: 19 giugno 2015).
[7] Spence, J.H. 2008. What Is Wrong with Cloning a Dinosaur? Jurassic Park and Nature as a Source of Moral Authority. In: Kowalski, D (ed.). Steven Spielberg and Philosophy: We're Gonna Need a Bigger Book. Lexington: The University Press of Kentucky. pp. 97-111.
[7bis] Ibidem.
[8] Crichton, M. 2004. Why Politicized Science is Dangerous (Excerpted from State of Fear). Michael Crichton: The Official Site, <http://www.michaelcrichton.net/essay-stateoffear-whypoliticizedscienceisdangerous.html> (ultimo accesso: 19 giugno 2015).
[7bis] Ibidem.
[8] Crichton, M. 2004. Why Politicized Science is Dangerous (Excerpted from State of Fear). Michael Crichton: The Official Site, <http://www.michaelcrichton.net/essay-stateoffear-whypoliticizedscienceisdangerous.html> (ultimo accesso: 19 giugno 2015).
[9] Becker, S. 2008. We Still Can’t Clone Dinosaurs. In: Grazier, K (eds.). The Science of Michael Crichton: An Unauthorized Exploration Into the Real Science Behind the Fictional Worlds of Michael Crichton, pp. 69-84. Dallas: Benbella Books. pp. 69-84: 82.
[9bis] Ibidem.
[9bis] Ibidem.
[10] Ibi: 83-84.
[11] Si veda quanto affermato da Crichton in The Making of Jurassic Park (1993), cit. in Milner, R. 2009. s.v. “Jurassic Park”. In: Darwin’s Universe: Evolution from A to Z, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press. pp. 250-252.
[12] Ambasciano, L. 2014. Sciamanesimo senza sciamanesimo. Le radici intellettuali del modello sciamanico di Mircea Eliade: evoluzionismo, psicoanalisi, te(le)ologia. Roma: Nuova Cultura. pp. 505-506.
[13] Ceruti, M. 2009. Il vincolo e la possibilità. Milano: Cortina. pp. 42-43.
[14] Medawar, P.B. 1970. Induzione e intuizione nel pensiero scientifico. Roma: Armando Editore. pp. 58-59 (ed. orig. pubbl. nel 1969 come Induction and Intuition in Scientific Thought. Philadelphia: American Philosophical Society).
[15] Pievani, T. 2012. La fine del mondo. Guida per apocalittici perplessi. Bologna: il Mulino. p. 47.
[15bis] Ibi: 90.
[16] Ibi: 90-91.
[11] Si veda quanto affermato da Crichton in The Making of Jurassic Park (1993), cit. in Milner, R. 2009. s.v. “Jurassic Park”. In: Darwin’s Universe: Evolution from A to Z, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press. pp. 250-252.
[12] Ambasciano, L. 2014. Sciamanesimo senza sciamanesimo. Le radici intellettuali del modello sciamanico di Mircea Eliade: evoluzionismo, psicoanalisi, te(le)ologia. Roma: Nuova Cultura. pp. 505-506.
[13] Ceruti, M. 2009. Il vincolo e la possibilità. Milano: Cortina. pp. 42-43.
[14] Medawar, P.B. 1970. Induzione e intuizione nel pensiero scientifico. Roma: Armando Editore. pp. 58-59 (ed. orig. pubbl. nel 1969 come Induction and Intuition in Scientific Thought. Philadelphia: American Philosophical Society).
[15] Pievani, T. 2012. La fine del mondo. Guida per apocalittici perplessi. Bologna: il Mulino. p. 47.
[15bis] Ibi: 90.
[16] Ibi: 90-91.